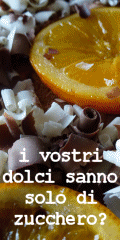Harmonia Caelestis
Giugno 6, 2004 in Libri da Stefano Mola
| Titolo: | Harmonia Caelestis |
| Autore: | Péter Esterházy |
| Casa editrice: | Feltrinelli |
| Prezzo: | € 22.00 |
| Pagine: | 716 |
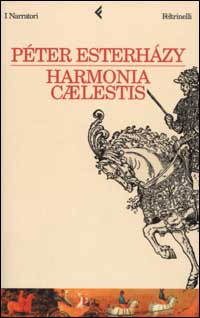 Péter Esterházy, nato nel 1950 a Budapest, studi matematici, discende da una famiglia di principi un tempo tra le più importanti del suo paese e dell’intera Europa. In prima approssimazione, per così dire, questo libro sterminato e difficilmente imbrigliabile, ne racconta la storia, suddividendola in due parti. La prima è dedicata al periodo della potenza e dello splendore. Prende l’avvio dal XVI secolo: a quel tempo gli Esterházy erano padroni di mezza Ungheria, possedevano città, castelli e terre di una tale vastità che per sorvolarle nemmeno alle anitre selvatiche bastava una sola notte. La seconda parte racchiude un tempo molto più breve. Ha inizio con l’avvento della dittatura comunista e racconta la caduta della casata: tutti i beni degli Esterházy furono infatti confiscati. L’autore stesso entra in gioco come personaggio, descrivendo la propria infanzia tra gli stenti e le difficoltà imposte dal nuovo regime, la passione per il gioco del calcio.
Péter Esterházy, nato nel 1950 a Budapest, studi matematici, discende da una famiglia di principi un tempo tra le più importanti del suo paese e dell’intera Europa. In prima approssimazione, per così dire, questo libro sterminato e difficilmente imbrigliabile, ne racconta la storia, suddividendola in due parti. La prima è dedicata al periodo della potenza e dello splendore. Prende l’avvio dal XVI secolo: a quel tempo gli Esterházy erano padroni di mezza Ungheria, possedevano città, castelli e terre di una tale vastità che per sorvolarle nemmeno alle anitre selvatiche bastava una sola notte. La seconda parte racchiude un tempo molto più breve. Ha inizio con l’avvento della dittatura comunista e racconta la caduta della casata: tutti i beni degli Esterházy furono infatti confiscati. L’autore stesso entra in gioco come personaggio, descrivendo la propria infanzia tra gli stenti e le difficoltà imposte dal nuovo regime, la passione per il gioco del calcio.
Fin qui, verrebbe da dire, nulla di particolarmente nuovo: di saghe familiari la letteratura è piena, così come di ascese e cadute che raccontano un’epoca e una società. Un nome su tutti, quel libro straordinario che è I Buddenbrok. Inoltre, questo tipo di narrativa sembrerebbe presupporre implicitamente la linearità, camminando a fianco delle generazioni che si succedono. Ma questo libro è tutt’altro che lineare e armonico, e dunque forse pienamente novecentesco. Quell’armonia del titolo è del tutto ingannevole. Come ha scritto il critico ungherese Laszlo Foldény Quest’opera conclude la letteratura del ventesimo secolo. Non la si deve leggere solo come la storia della famiglia Esterházy. Tutta la vita terrena è un gigantesco labirinto a specchi. Tutto splende e scintilla come un enorme lampadario barocco.
Il racconto, condotto in prima persona, procede per frammenti, di lunghezza diseguale. Possono essere poche righe, oppure diverse pagine. Soprattutto nella prima parte, frequenti sono i salti temporali da un frammento all’altro. La voce narrante appartiene sempre a un figlio, che quasi sempre racconta del padre, chiamandolo mio buon padre. Questi sono gli unici elementi comuni, anche se non è sempre immediatamente identificabile di quale figlio e di quale buon padre si stia in un certo momento parlando. Sembrerebbe quindi non tanto importante la storia in sé, nel senso classico e cronologico, quanto il legame famigliare. E del resto, all’inizio l’autore ci dice: La famiglia è l’insieme di persone legate tra loro da comune discendenza, da identità di passato storico, da legami di sangue. Il rispetto dei maggiori e la venerazione della loro memoria sono alla base dell’amore per la famiglia e, sia detto una volta per sempre, dell’amor di patria. Perciò quella famiglia che trascura il proprio passato e non onora la memoria dei suoi avi recide alla radice l’albero della vita della propria nazione etcetera [pag. 14].
Pienamente novecentesco, quindi, per l’effrazione della linearità e della consequenzialità. Matematico anche, ma ancora una volta, nel senso della matematica novecentesca. Mi vengono in mente due immagini. La prima ha a che fare con il caos. La matematica moderna ha mostrato che nel caos a volte è possibile ritrovare delle leggi, delle strutture, a patto di andare al di là delle dimensioni intere. Penso ai frattali, penso al concetto di autosimilitudine. Il caos della narrazione potrebbe essere dunque un ordine per autosimilitudine, dove il più grande (il più antico) si riflette scalato nel più piccolo (il più nuovo)? Forse, perché alla fine un insieme che raccoglie tutto a denominatore comune c’è, ed è appunto l’appartenenza alla stessa famiglia.
La seconda immagine è quella di alcuni edifici antichi. Spesso, a guardare bene, possiamo trovare in una struttura frammenti di costruzioni del passato. In alcune chiese cristiane possiamo ritrovare pezzi di edifici romani, o addirittura abbiamo esempi di chiese elevate utilizzando strutture di moschee pre-esistenti. A rigor di logica, anche questo potrebbe sembrare disarmonico, ma allo stesso tempo esiste un’unità costruita sulla diversità degli elementi costituenti, generata dal processo storico. L’unità nel senso di un mosaico. Scendendo al livello del singolo frammento c’è sicuramente una discontinuità, che scompare e si carica di senso solo a livello dell’insieme.
Questa struttura si può reggere soltanto su una scrittura estremamente leggera, ironica, fondamentalmente ottimistica, capace di girare attorno a ogni pesantezza, oppure di librarsene al di sopra (penso all’esame che fa Calvino della novella del Boccaccio dove viene riportato il salto di Guido Cavalcanti), e che, oltre ai grandi avvenimenti pubblici dà anche risalto alle vicende dell’eros.
di Stefano Mola