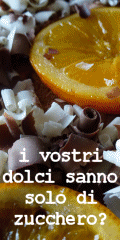Castagne a colazione
Dicembre 1, 2003 in Libri da Gustare da Marinella Fugazza
Salvatore Marchese – Castagne a colazione E poi a pranzo e a cena – Franco Muzzio Editore, pagg. 216, Euro 12.50
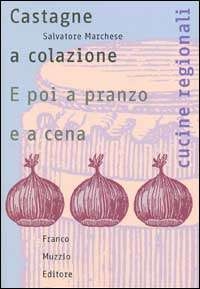 Le castagne sono più buone da mangiare se tostate. Macinate diventano una sorta di pane così si esprimeva il latino Plinio a proposito di un frutto che ha risolto per secoli le necessità alimentari di gran parte della popolazione. Il libro di Salvatore Marchese, Castagne a colazione E poi a pranzo e a cena è un’importante testimonianza, non solo culinaria, del rilievo culturale della castagna nella produzione e nella storia alimentare. L’autore dipana la sua ricerca come un racconto dove i diversi capitoli tematici forniscono piacevoli spunti, curiosità e stimoli che rendono la lettura scorrevole ed attenta. E così, pagina dopo pagina, si viene a conoscenza che nel Medio Evo all’inizio dell’autunno, epoca nella quale avviene il raccolto delle castagne (la data che fissa l’inizio è il 29 settembre, il giorno dopo San Michele), venivano appositamente interrotti i combattimenti per consentire a tutti di mettere da parte una fondamentale risorsa alimentare; proprio a partire da quel periodo storico il castagno diventò l’”albero del pane” perché, al pari del maiale, sfruttato completamente: la farina, il legno per gli arredi e le botti, il tannino per la concia dei pellami, le foglie secche per il giaciglio, il terriccio fertilissimo per fiori e funghi porcini.
Le castagne sono più buone da mangiare se tostate. Macinate diventano una sorta di pane così si esprimeva il latino Plinio a proposito di un frutto che ha risolto per secoli le necessità alimentari di gran parte della popolazione. Il libro di Salvatore Marchese, Castagne a colazione E poi a pranzo e a cena è un’importante testimonianza, non solo culinaria, del rilievo culturale della castagna nella produzione e nella storia alimentare. L’autore dipana la sua ricerca come un racconto dove i diversi capitoli tematici forniscono piacevoli spunti, curiosità e stimoli che rendono la lettura scorrevole ed attenta. E così, pagina dopo pagina, si viene a conoscenza che nel Medio Evo all’inizio dell’autunno, epoca nella quale avviene il raccolto delle castagne (la data che fissa l’inizio è il 29 settembre, il giorno dopo San Michele), venivano appositamente interrotti i combattimenti per consentire a tutti di mettere da parte una fondamentale risorsa alimentare; proprio a partire da quel periodo storico il castagno diventò l’”albero del pane” perché, al pari del maiale, sfruttato completamente: la farina, il legno per gli arredi e le botti, il tannino per la concia dei pellami, le foglie secche per il giaciglio, il terriccio fertilissimo per fiori e funghi porcini.
Gli aculei dei ricci venivano considerati scherzi del Diavolo e gli stessi ricci quando lasciano cadere i frutti maturi si dischiudono a forma di croce evidente segno del Signore. Tre, numero perfetto e simbolico, sono di solito le castagne racchiuse in un riccio (che contiene un solo marrone). I bambini nascevano sotto un cavolo, ma anche nel cavo di un tronco di castagno. La castagna entra in tutto e per tutto nella vita di ogni giorno: nel folclore, nella ritualità sacrale e nell’economia famigliare. Il castagneto era considerato giustamente fonte di ricchezza, un bene di famiglia al quale attendere con cura: lussureggianti castagneti sono situati in Toscana (Mugello, Monte Amiata, Garfagnana e Lunigiana), Lazio (Monte Cimini), Campania (Avellino, Caserta, Benevento). Risalendo la penisola, spesso seguendo la dorsale appenninica, si incontra questo antichissimo frutto in Emilia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. L’albero più maestoso ed antico si trova però in Sicilia e precisamente sull’Etna nei pressi del centro abitato di Sant’Alfio: Il Castagno dei Cento Cavalli ha un’età indefinibile ma sembrerebbe aggirarsi tra i 2000 e 4000 anni; la sua circonferenza, misurata più volte, si può ragionevolmente fissare prossima ai 60 metri.
Il libro è ricchissimo di curiosità, di proverbi, di storie popolari, di aneddoti su questo appetitoso e “puro” frutto; puro perché adeguatamente protetto dal riccio, dalla scorza e dalla resistentissima pellicina nei confronti dell’inquinamento atmosferico. Le pagine scorrono, nella prima parte, fra leggenda e storia, fra fantasia e tradizione, fra necessità salutari e necessità alimentari. La seconda parte è un tripudio alle svariate interpretazioni della castagna in cucina; le sue proprietà organolettiche e nutrizionistiche vengono esaltate nelle ricette di alcuni cuochi amici dell’autore i cui ristoranti vengono citati al termine del volume. Leggendole si rimane stupiti non solo della fantasia di coloro i quali le hanno elaborate ma anche dalla versatilità del frutto. Come non volere provare un antipasto di “Timballo di castagne con mousse al lardo”? , per poi continuare con delle “Lasagnette matte al pesto di mortaio”? proseguire con una “Tasca di faraona ripiena” e terminare con un “Bonet di castagne bianche? Logicamente ognuno di noi può sbizzarrirsi alla ricerca del menù “castagnicolo” più vicino al suo palato ed ai suoi gusti non trascurando di “aiutare la digestione” con una “Grappa ai marron glacè”.
di Marinella Fugazza