TraspiCampiello03
Agosto 28, 2004 in Libri da Stefano Mola
| Titolo: | La festa del ritorno |
| Autore: | Carmine Abate |
| Casa editrice: | Mondadori |
| Prezzo: | € 7.80 |
| Pagine: | 161 |
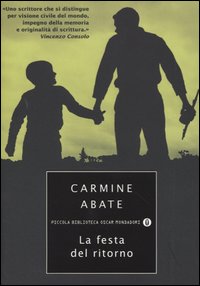 Le scintille ci avvolgevano, sembravano sciami d’api crepitanti; poi si azzittivano spegnendosi e ci cadevano sui capelli come una bufera di neve, e mio padre diceva che un fuoco così non si era mai visto, pare fatto apposta per schiaffarci dentro i ricordi più malamenti, diceva, e appicciarli in un lampobaleno, per sempre.
Le scintille ci avvolgevano, sembravano sciami d’api crepitanti; poi si azzittivano spegnendosi e ci cadevano sui capelli come una bufera di neve, e mio padre diceva che un fuoco così non si era mai visto, pare fatto apposta per schiaffarci dentro i ricordi più malamenti, diceva, e appicciarli in un lampobaleno, per sempre.
Questa è la bellissima immagine che apre La festa del ritorno, romanzo dello scrittore Carmine Abate, finalista al premio Campiello 2004. Il fuoco è quello del falò che viene acceso la notte di Natale, a Hora, paese della Calabria dove si parla arbëreshe, ovvero una lingua derivata dall’albanese. Chi racconta è Marco, il ragazzino tredicenne che insieme al padre osserva il consumarsi turbinoso della legna.
Il fuoco nasconde dentro di sé molti simboli. Passione, innanzi tutto. Quella che ci avvolge e non ci fa vedere nient’altro, che ci fa sentire vivi più che mai. Ma è anche quella che ci consuma, e che in assenza di un solido ancoraggio rischia di lasciare alle nostre spalle solo cenere. Quindi transitorietà: dei quattro elementi è il più instabile, volubile e misterioso. Acqua, terra e aria esistono per sé, in maniera naturale. Il fuoco dipende sempre da un intervento esterno: per questo forse collegato al sacro. Allo stesso tempo, è indubbiamente associato alla festa, allo stare insieme, al raccontare.
Nel romanzo, tutte queste componenti sono intrecciate e presenti. La festa che apre il libro è particolarmente intensa e sentita non solo perché si tratta del Natale, ma anche perché la vicinanza di padre e figlio non è una condizione quotidiana. La Calabria è anche terra di emigrazione: gli uomini sono costretti a rincorrere il lavoro nei paesi del nord. Come il padre di Marco, in Francia. Il rapporto tra Marco e il padre, forse anche per questo, è fortissimo. Il ragazzo vive una profonda nostalgia carica di affetto e attaccamento. Una delle grandi qualità di questo libro sta nella descrizione del sentimento di Marco per il padre, le attese, le esplosioni di gioia al suo arrivo, il dolore malinconico della partenza. Abate riesce a farci sentire tutto questo attraverso una lente poetica e lieve, senza cadere nel facile sentimentalismo, ma con una freschezza che sembra far accadere le cose nello stesso tempo in cui vengono vissute attraverso gli occhi del ragazzo. Particolarmente intensi sono i momenti in cui Marco e il padre vanno in giro inoltrandosi nella natura che circonda il paese. Qui le parole e i silenzi tra loro si fondono ai colori, agli odori, ai sapori dei cibi, ai paesaggi, agli animali.
Il padre non è soltanto un grande, un adulto da guardare dal basso, come una statua. Poco alla volta, davanti al fuoco, vengono fuori debolezze, difficoltà, orgoglio, indecisioni, i problemi di una vita sradicata per lavoro. È come nel racconto, a poco a poco, il padre venisse incontro a Marco, che sta oscuramente intuendo che cosa vuole dire crescere.
Ma come abbiamo detto all’inizio, fuoco vuol dire passione, e anche mistero. Dobbiamo infatti ancora parlare del terzo personaggio attorno cui ruota il romanzo: Elisa, la sorella maggiore di Marco. Lei ha fatto il salto epocale, perché studia all’università, a Cosenza e sembra così diversa da Marco, anche esteticamente. E talvolta si comporta in modo strano, come se avesse un segreto. Come se vivesse un amore nascosto, che non può essere detto. Elisa è un altro modo di vivere l’assenza del padre, ed è una specie di motore immobile della maturazione di Marco, il filo che inconsapevolmente avvicinerà ancora di più padre e figlio.
Il romanzo così si sviluppa alternando la storia di emigrazione del padre e le vicende quotidiane di Marco. Le due linee si intrecciano attorno al fuso rappresentato dal mistero di Elisa, visto dalle due parti. Meglio non dire di più, per non guastare la storia al lettore.
Del tono e del timbro di questo bel libro si è già più sopra detto. Ancora due parole sulla lingua: un altro esempio di felice impasto tra italiano e termini imprestati dal dialetto, con alcune leggere intrusioni di arbëresh. Ma anche qui, la sintesi è riuscita: il dialetto e l’arbëresh fungono da spezie, sono tocchi a sbalzo per farci sentire con più vita e vivacità una vicenda e un modo di vivere che è toccato in sorte a molti, non solo in Calabria.
di Stefano Mola
