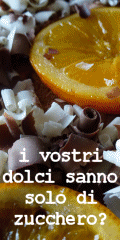TraspiCampiello
Settembre 8, 2002 in Libri da Stefano Mola
Nico Orengo, “La curva del Latte”, Einaudi, pp. 213, Euro 14,00
.jpg) Nico Orengo ci racconta la storia di Latte, ponente ligure, pochi chilometri dalla frontiera con la Francia, nel 1957. Un anno in cui sottovoce inizia il passaggio da “Poche case, sparse lungo la strada e sulla piana: tutto il resto erano coltivazioni di garofani, rose, calle, sterlizie, ginestra, plumoso. E intorno uliveti, macchie di eucalipto e mimosa” [pag. 16] a quello che è la riviera adesso. Lo fa dipanando e intrecciando le storie degli abitanti: i compagni ex-partigiani Libero, Martì, Luisò, Baciui, Mario, le armi della resistenza ancora seppellite; Jolanda, ragazza madre (ricordiamoci, 1957), Dora che spera nell’eredità d’un pezzo di terra, la lucida e sognatrice maestra in pensione Canziani, il giornalaio Salvai e le sue navi in bottiglia, il maestro immigrato Puglisi che nel tempo libero lavora alla composizione di una canzone dal titolo “Nel mare dipinto di blu”…
Nico Orengo ci racconta la storia di Latte, ponente ligure, pochi chilometri dalla frontiera con la Francia, nel 1957. Un anno in cui sottovoce inizia il passaggio da “Poche case, sparse lungo la strada e sulla piana: tutto il resto erano coltivazioni di garofani, rose, calle, sterlizie, ginestra, plumoso. E intorno uliveti, macchie di eucalipto e mimosa” [pag. 16] a quello che è la riviera adesso. Lo fa dipanando e intrecciando le storie degli abitanti: i compagni ex-partigiani Libero, Martì, Luisò, Baciui, Mario, le armi della resistenza ancora seppellite; Jolanda, ragazza madre (ricordiamoci, 1957), Dora che spera nell’eredità d’un pezzo di terra, la lucida e sognatrice maestra in pensione Canziani, il giornalaio Salvai e le sue navi in bottiglia, il maestro immigrato Puglisi che nel tempo libero lavora alla composizione di una canzone dal titolo “Nel mare dipinto di blu”…
Sullo sfondo, il lancio dello Sputnik, e soprattutto la politica, democristiani contro comunisti. Perché “Quando Latte era un bel paese si discuteva molto […] Tutti discutevano gli assetti mondiali del pianeta e di converso quelli locali. Tutti molto settari in sezione e trasversali intorno a un mazzo di carte, una partita a biliardo, un equipaggio da pesca o una battuta di caccia. Tutti, meno Ingiustin […] E dunque la prima mossa per rendere brutto, e nel tempo orribile, il paese di Latte non poté che partire da lui” [pag. 17].
Qui c’è già molto. La svolta (la curva del titolo si può anche leggere così, la deviazione da un altro cammino), la perdita di un paesaggio e forse del senso di una comunità partono proprio da chi, come Ingiustin, bada unicamente a mettere pompe di benzina e spacci di liquori al posto di ristoranti. Ma non vorrei andare troppo in là, dare l’idea che questo romanzo sia una specie di studio socio-economico sulla trasformazione dell’Italia subito prima del boom. In primo luogo questo libro, vale la pena ripeterlo, racconta delle storie: ci sono anche uno scimmione forse risultato di esperimenti di un oscuro medico, la scomparsa e il ritrovamento della testa della madonna, la radio della maestra che capta dall’aldilà la voce del fascista Rosolino.
E lo fa con leggerezza, con ironia lieve, sorniona, con affetto per tutti i personaggi che descrive. Persino quelli che potremmo mandare alla sbarra come principali imputati dello scempio, come Balabin, ricevono in dono pagine di grazia: “Lo avevano soprannominato Balabin non perché fosse un re del tango o di mazurca, ma perché possedeva un equilibrio da stambecco, e i più maligni dicevano: anche le corna. Balabin passava le sue giornate in piedi sulla prua o sulla poppa del suo gozzo […] a ispezionare fazzoletti di terra. Golosamente si annotava i punti panoramici, strade e sentieri di collegamento con l’Aurelia. […] Poi sognava di strappar rose, garofani, ginestre, mimose e sostituirle con villette, studiò, alberghi e financo condomini” [pag. 176].
Una leggerezza nel segno di quella che descrive Calvino nella prima delle sue “Lezioni americane”. Dire le cose senza farsi trascinare a fondo dallo loro opprimente pesantezza: “la leggerezza è qualcosa che si crea nella scrittura, con i mezzi linguistici che sono quelli del poeta, indipendentemente dalla dottrina del filosofo che il poeta dichiara di voler seguire” (Lezioni americane, pag. 14 dell’edizione Mondadori, 1999). C’è un’immagine molto bella che usa Calvino. Cita il mito di Perseo e della Medusa e dice: “Dal sangue della medusa nasce un cavallo alato, Pegaso; la pesantezza della pietra può essere rovesciata nel suo contrario” (pag. 9). Curiosamente, a voler trovare delle coincidenze, è proprio nel 1957 che Calvino esce dal PCI e pubblica quel capolavoro della leggerezza che è “Il barone rampante”.
La leggerezza ha il suo risvolto nella rigidezza ideologica dei personaggi maschili, il gruppo di Libero. Ancorati alla speranza (e non poteva essere diversamente) della rivoluzione, nella comica ricerca di “tenere in mano” il paese (che tra le altre cose vuol dire cercare di capire chi possa aver messo incinta Jolanda, o cacciare lo scimmione…) vengono inesorabilmente lasciati indietro dalla realtà: le trasformazioni volute da Ingiustin o i movimenti di Balabin restano per loro sullo sfondo, così come non riescono a gestire la novità del comportamento orgoglioso di Jolanda, per i tempi realmente rivoluzionario. Del resto, sono proprio i personaggi femminili ad essere i più duttili, i più vicini alla concretezza delle cose (pensando al gruppo di Libero mi viene in mente la canzone di Gaber “La realtà è un uccello”).
Anche se Libero e i suoi in fondo più che il simbolo di una ideologia come tenaglia inefficace nell’afferrare il reale, sono l’emblema di una speranza ingenua e disattesa: “Libero, seduto in angolo, ascoltava infastidito. Quelle continue beghe fra socialdemocratici e socialisti, fra socialisti e comunisti, gli facevano rimpiangere il tempo in cui i nemici erano i nazi e i fasci, e quelli che erano dalla stessa parte non dovevano esibire troppe sfumature, linee programmatiche. Erano tutti compagni di lotta. […] Nella sua visione pacifica e lineare della vita, libero vedeva un solo partito non borghese, un partito dei lavoratori, un partito della sinistra, unito e forte. E si chiedeva perché non doveva essere possibile. Non voleva dirselo, ma la risposta forse era perché esistevano uomini come Ercole: agitatori insoddisfatti, che cercavano lo scontro in nome di un uomo nuovo, di una società perfetta. Uno così non era mai vissuto in campagna, non era andato a pesca o a caccia” [pag. 113].
La cosa più importante è che alla fine abbiamo un racconto godibilissimo. Insomma, è come se ci venisse detto, ecco, qui ci sono in primo luogo queste storie di persone, storie normali, a volte un po’ comiche, a volte un po’ strane. Poi certo, ad andare a vedere bene, ad ascoltare i segnali, c’è tutto il resto, c’è questa svolta verso lo scempio e i suoi responsabili, però come una specie di retrogusto che sia accompagna al divertimento della lettura. Perché sulla letteratura si possono fare tante teorie, così come si possono scrivere parole e parole per descrivere un bicchiere di vino (il colore, l’odore, il retrogusto, i tannini, il barricato…) ma alla fine, la cosa migliore che si può fare con quel bicchiere è provare piacere nel berlo.
Un’altra cosa molto bella è il legame profondo a questo angolo di Liguria e alla sua natura (o a quello che ne resta): “Era marina. Sotto Mamante, l’acqua batteva di tardo ottobre, onda breve e schiuma nell’azzurro del mare. Era mare ancora femmina, appena di mattina, un soffiare intorpidito che su quei pochi scogli sbatteva e s’aggrovigliava di sbadiglio, di sonno sollevato dal cuscino, di indecisione e pigrizia nell’avvolgersi breve sull’affiorare della roccai, tra muschio e patella, sotto la casa del maestro Puglisi” [pag. 103].
Ecco alcuni link:
Interviste a Nico Orengo: su Infinitestorie , su Viamichelin , sul sito Einaudi .
La recensione di Michele Serra.
Se volete ripassare un po’ di storia, la cronologia del 1957, sull’ottimo sito www.cronologia.it.
Il testo della canzone di Gaber citata nella recensione.
di Stefano Mola