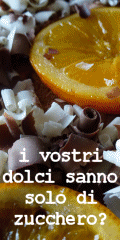La piena maturità kirchneriana
Maggio 15, 2002 in Medley da Sonia Gallesio
 Intorno al 1910 gli artisti della Brucke, che intanto aveva accolto grandi personalità quali Otto Mueller e Emil Nolde, cominciano a muoversi verso specifiche e personali direzioni, causando un progressivo scioglimento del forte legame fino ad allora esistito. Lo stesso Kirchner si allontana piuttosto presto dalla realtà compositiva espressionista dell’associazione, per poter elaborare liberamente la sua sentita visione degli spazi e della fisicità umana. Nell’ottobre del 1911 Ernst Ludwig lascia Dresda trasferendosi a Berlino, nota metropoli fiorente d’industria e di commercio ma anche capitale del sapere e dell’ingegno. Grandi uomini si muovono in quel tempo alle volte della modernità: sono gli anni, ad esempio, in cui i drammi di Ibsen e di Strindberg riempiono i più importanti teatri. La permanenza berlinese di Kirchner si rivela uno dei periodi più fecondi della sua carriera artistica: a partire da questo momento, sarà la componente psicologica ed emotiva a determinare con rilevanza colori e forme. In Germania lo stile kirchneriano si delinea sempre più, nonostante traspaia un interessante legame con l’arte indiana classica, con evidenti riferimenti agli affreschi buddisti del VI secolo d.c., riscontrabile nelle rinnovate rotondità dei corpi femminili (si osservi, in mostra, l’opera “Due ragazze al bagno”, 1911). Gli influssi dell’arte indiana si mescolano e si fondono con gli spunti forniti dalla produzione di Matisse e con le suggestioni scultoree africane. Inevitabile è altresì l’incontro con il futurismo italiano che, esprimendo energia, fervore e dinamicità, si concentra maggiormente sulla nuova vita metropolitana.
Intorno al 1910 gli artisti della Brucke, che intanto aveva accolto grandi personalità quali Otto Mueller e Emil Nolde, cominciano a muoversi verso specifiche e personali direzioni, causando un progressivo scioglimento del forte legame fino ad allora esistito. Lo stesso Kirchner si allontana piuttosto presto dalla realtà compositiva espressionista dell’associazione, per poter elaborare liberamente la sua sentita visione degli spazi e della fisicità umana. Nell’ottobre del 1911 Ernst Ludwig lascia Dresda trasferendosi a Berlino, nota metropoli fiorente d’industria e di commercio ma anche capitale del sapere e dell’ingegno. Grandi uomini si muovono in quel tempo alle volte della modernità: sono gli anni, ad esempio, in cui i drammi di Ibsen e di Strindberg riempiono i più importanti teatri. La permanenza berlinese di Kirchner si rivela uno dei periodi più fecondi della sua carriera artistica: a partire da questo momento, sarà la componente psicologica ed emotiva a determinare con rilevanza colori e forme. In Germania lo stile kirchneriano si delinea sempre più, nonostante traspaia un interessante legame con l’arte indiana classica, con evidenti riferimenti agli affreschi buddisti del VI secolo d.c., riscontrabile nelle rinnovate rotondità dei corpi femminili (si osservi, in mostra, l’opera “Due ragazze al bagno”, 1911). Gli influssi dell’arte indiana si mescolano e si fondono con gli spunti forniti dalla produzione di Matisse e con le suggestioni scultoree africane. Inevitabile è altresì l’incontro con il futurismo italiano che, esprimendo energia, fervore e dinamicità, si concentra maggiormente sulla nuova vita metropolitana.
A partire dalla seconda metà del 1912, Kirchner comincia a produrre il noto nucleo di opere raffiguranti la vita berlinese, che rimarrà a lungo icona indimenticabile del suo genio, perfettamente in linea con l’interesse che il futurismo italiano aveva alimentato nei confronti del fermento cittadino. L’ambiente urbano, possiamo proprio dirlo, viene dall’artista psicologizzato, reso vibrante e nervoso partendo, forse, più da una predisposizione interiore che dal bisogno di interpretare i fatti nel modo più veritiero possibile. Proprio a questo punto, per Kirchner, la modella si fa mezzo interpretativo della realtà metropolitana, fino ad arrivare alla realizzazione delle cosiddette “scene di strada”, la cui raccolta costituirà il fulcro della sua produzione tedesca: siamo alla fine del 1913 e le prostitute a passeggio per le vie diventano le indiscusse protagoniste. Gli accadimenti del lungo periodo a partire dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale fino al trasferimento dell’artista in Svizzera, travolgono – come un fiume in piena – la sua emotività ed il suo già precario equilibrio, influenzando notevolmente le sue condizioni di salute e la sua produzione. Kirchner, attanagliato dall’angoscia e stordito dallo smarrimento, si abbandona irrimediabilmente all’abuso di alcool e droghe per cadere ben presto vittima della malattia e dover ricorrere, infine, a ripetuti soggiorni in svariate case di cura. Messo a dura prova, sembra in questi anni lavorare a nervi scoperti, senza alcun tessuto o strato protettivo a filtrare le sollecitazioni esterne; diviene molto più sensibile e ricettivo nei confronti degli eventi ma anche dei moti interiori. In questo periodo si intensifica la realizzazione di opere grafiche, a discapito della pittura. Leggerezza e serenità abbandonano la produzione di Kirchner per lasciare il posto a rappresentazioni fosche e talvolta torbide, innaturali, contratte.
.jpg) Nel 1917 l’artista parte per Davos (Svizzera) dove, dopo diverse vicissitudini e spostamenti, rimarrà fino alla fine dei suoi giorni. I problemi di salute che lo hanno torturato fino ad allora non lo risparmiano ed, anzi, peggiorano. Nel 1818 realizza grandiose xilografie che trasferiscono una forte carica emotiva e spirituale, dalle percettibili contaminazioni simboliste [si analizzi “Testa di malato (Autoritratto)”]. Osservando l’ambiente che avvolge la sua “casa tra i larici”, comincia a rappresentare gli intensi paesaggi che lo circondano, lasciandosi pian piano soggiogare dalla potenza e dal fascino sublime dei colori delle Alpi. Proprio a partire da questo incontro, si percepirà via via un nuovo stato d’animo che mai prima d’allora si era ravvisato: la malinconia. L’arte di Kirchner si rinnova costantemente e, ben presto, termina anche la fase del paesaggismo alpino. Egli stesso scrive: “L’arte è mutamento continuo, e invecchiare dentro uno schema consuetudinario è artigianato, non arte”. A partire dal 1925, si confronta con la contemporaneità in modo molto produttivo, con il preciso fine di proporre un “Kirchner nuovo”. La costruzione geometrica dei suoi dipinti, rispetto alle opere degli anni tedeschi, viene di molto semplificata; l’artista si serve, in prevalenza, di una scansione orizzontale e verticale della superficie pittorica, evitando di riprodurre prospettive singolari e tensioni energizzanti. Dopo il 1935, in concomitanza con l’avanzare della gelida minaccia nazista, dipinge molti quadri che è possibile considerare visioni complessive e riassuntive dei suoi trascorsi personali ed artistici, incisive metafore ed allegorie che testimoniano eccezionalmente la profonda consapevolezza di sé. Dal 1937, dopo essere stato etichettato in Germania, dai nazionalsocialisti, quale “artista degenerato”, si distacca sempre più dagli avvenimenti esterni, di natura politico-sociale, per tessere un legame di corrispondenze più fitto con la dimensione naturale ed, ancora, lasciarsi sedurre dai richiami melanconici. Kirchner si suiciderà nel suo studio, con un colpo di pistola, nel giugno 1938.
Nel 1917 l’artista parte per Davos (Svizzera) dove, dopo diverse vicissitudini e spostamenti, rimarrà fino alla fine dei suoi giorni. I problemi di salute che lo hanno torturato fino ad allora non lo risparmiano ed, anzi, peggiorano. Nel 1818 realizza grandiose xilografie che trasferiscono una forte carica emotiva e spirituale, dalle percettibili contaminazioni simboliste [si analizzi “Testa di malato (Autoritratto)”]. Osservando l’ambiente che avvolge la sua “casa tra i larici”, comincia a rappresentare gli intensi paesaggi che lo circondano, lasciandosi pian piano soggiogare dalla potenza e dal fascino sublime dei colori delle Alpi. Proprio a partire da questo incontro, si percepirà via via un nuovo stato d’animo che mai prima d’allora si era ravvisato: la malinconia. L’arte di Kirchner si rinnova costantemente e, ben presto, termina anche la fase del paesaggismo alpino. Egli stesso scrive: “L’arte è mutamento continuo, e invecchiare dentro uno schema consuetudinario è artigianato, non arte”. A partire dal 1925, si confronta con la contemporaneità in modo molto produttivo, con il preciso fine di proporre un “Kirchner nuovo”. La costruzione geometrica dei suoi dipinti, rispetto alle opere degli anni tedeschi, viene di molto semplificata; l’artista si serve, in prevalenza, di una scansione orizzontale e verticale della superficie pittorica, evitando di riprodurre prospettive singolari e tensioni energizzanti. Dopo il 1935, in concomitanza con l’avanzare della gelida minaccia nazista, dipinge molti quadri che è possibile considerare visioni complessive e riassuntive dei suoi trascorsi personali ed artistici, incisive metafore ed allegorie che testimoniano eccezionalmente la profonda consapevolezza di sé. Dal 1937, dopo essere stato etichettato in Germania, dai nazionalsocialisti, quale “artista degenerato”, si distacca sempre più dagli avvenimenti esterni, di natura politico-sociale, per tessere un legame di corrispondenze più fitto con la dimensione naturale ed, ancora, lasciarsi sedurre dai richiami melanconici. Kirchner si suiciderà nel suo studio, con un colpo di pistola, nel giugno 1938.
La Fondazione Mazzotta omaggia Kirchner
Kirchner e la Brucke espressionista
di Sonia Gallesio