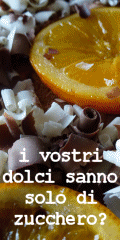L’alba di un mondo nuovo
Giugno 15, 2003 in Libri da Stefano Mola
Alberto Asor Rosa, “L’alba di un mondo nuovo”, Einaudi, pp. 326, Euro 18,00
.jpg)
Si può definire “romanzo” un libro che è sostanzialmente rievocazione autobiografica della propria infanzia? Ecco la prima questione che pone l’esordio narrativo del critico Alberto Asor Rosa. Abbiamo invece di fronte un “racconto reale”, come quello che vorrebbe scrivere Javier, protagonista de “Soldati di Salamina”, altro finalista del Grinzane? (di cui potete leggere qui a fianco)
Tra le tesi del romanzo di Cercas troviamo: 1) ogni narratore è inventato; 2) un racconto reale è impossibile perché esiste il punto di vista di chi racconta, che distorce i fatti da come sono realmente avvenuti. E che, viste le premesse, non potremmo in definitiva mai conoscere. Conseguentemente, anche raccontare la propria storia significherebbe quindi inventare un se stesso diverso da quello che realmente è stato.
Al di là di questi sofismi, qual è l’operazione compiuta da Asor Rosa? Partiamo dall’inizio, ovvero da quel saggio sulla memoria che è il primo capitolo. In cui troviamo, ad esempio, questa frase: “Mentre ‘capire’ e ‘fare’ dipendono dall’uomo, l’uomo dipende dalla memoria, la quale non ci sarebbe, ovviamente, se lui non ci fosse, ma, una volta che lui c’è, si governa da sé, va dove vuole, e quasi sempre senza che riesca a capire perché.” [pag. 5]
Scrivere del proprio passato potrebbe allora significare cercare di seguire i meccanismi della memoria, in un percorso dove ciò che si racconta potrebbe essere altrettanto importante di quello che si tace. E che rimarrebbe silenzio anche per motivi indipendenti dalla volontà dell’autore, imperscrutabile ostaggio della sua stessa memoria.
Perché, come si dice più avanti, “quel filo, nella memoria, è pieno di nodi, intrecci, rimandi e imbrogli: ci sono dei momenti in cui, per quanto ci sia dia da fare, il filo resiste a tutti gli sforzi e non si sdipana, oppure al contrario porta in una direzione del tutto imprevista e sorprendente; e ce ne sono altri in cui si direbbe che il gomitolo s’apra di colpo, tutto insieme, e si ha la visione indimenticabile, estatica, di tutto ciò che è stato” [pag. 6]
Inoltre, nel senso di Cercas, qui l’invenzione del narratore è chiarissima: il punto di vista sulle cose è, o almeno cerca di essere, quello di un bambino. Con effetti quasi metafisici soprattutto nella descrizione delle proporzioni geometriche, della distanza fisica dai “grandi” e dalle cose.
Chiariti i confini entro cui questo libro si può definire narrativa, resta comunque un racconto particolarmente nitido di come poteva essere la vita a Roma e dintorni dal 1933 al 1945. Di come si andava a scuola e di come la campagna poteva avere ancora una dimensione mitologica, da età dell’oro, da contatto panico con la natura (si vedano le pagine sui soggiorni ad Artena). E quindi, c’è una duplice operazione di memoria: l’intersezione tra la storia personale e la Storia collettiva, in un periodo particolarmente drammatico. E su tutto, grazie allo stile preciso ed estremamente descrittivo di Asor Rosa, si stende un velo leggero di malinconia, forse inevitabile, per il tempo della propria infanzia.
di Stefano Mola