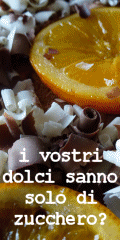L’omaggio italiano al Futurismo Russo
Aprile 3, 2002 in Medley da Sonia Gallesio
 Alla luce dei proficui rapporti, in ambito culturale, intessuti agli inizi del XX secolo da Italia e Russia, a partire dalle conferenze di Filippo Tommaso Marinetti, la Regione Autonoma Valle d’Aosta – organizzando la mostra Futurismo Russo – La sfida dell’Avanguardia – ci permette un’ampia analisi di tale movimento e delle sue varie evoluzioni. La vasta retrospettiva, presentandoci più di 200 opere, si rivela la mostra riguardante l’arte russa del primo ‘900 più esaustiva mai realizzata in Italia. Come spesso successe in occasione dei grandi movimenti artistici e di pensiero, i primi bagliori di quella che diventò poi un’audace e variegata corrente si ravvisarono nella letteratura. Il poema “Incantesimo col riso” di Velimir Chlebnikov, scritto tra il 1908 e il 1909, è da molti considerato il primo testo futurista russo: i versi che lo caratterizzano sono composti da parole inventate, generate utilizzando la radice “smech” (riso). La prima pubblicazione futurista, dal titolo “Il vivaio dei giudici” e della cui copertina troviamo in mostra una riproduzione, fu stampata nel 1910 su carta da parati, sfidando le reazioni degli intellettuali e del pubblico tutto. La direzione entusiasmante verso la quale gli uomini d’ingegno si mossero in campo letterario si concretizzò appunto in un’intensa sperimentazione linguistico-poetica, dalla quale ebbe origine il Linguaggio Zaum, presto adottato anche dal teatro, costituito da parole inventate, generate in totale libertà (zaum si traduce letteralmente “al di là della ragione”). Le applicazioni e l’intervento futuristi rivalutarono, inoltre, il potenziale dei dialetti e della terminologia colloquiale, che vennero largamente sfruttati. “Schiaffo al gusto del pubblico”, che rivelò le prime lodevoli ricerche sul linguaggio rivendicando il legittimo diritto degli autori ad arricchire il proprio vocabolario, risale al 1912 e fu il primo manifesto programmatico del movimento. I futuristi, i quali – ancora prima che una vera e propria corrente venisse identificata – solevano autodefinirsi budetljany (gente del futuro, coloro che saranno), tentarono di scuotere l’opinione pubblica e scioccare gli spettatori con gesti propagandistici estremi e fiumi di azioni provocatorie, spesso dando adito ad accese polemiche: si mostrarono per le vie delle città in abbigliamento estroso (note le giacche colorate di Vladimir Majakovskij), utilizzando accessori improbabili o ancora con il volto dipinto. Furono investiti da aspre critiche e attaccati per molto tempo da giornalisti ed esperti; addirittura si dubitò della sanità mentale di alcuni dei maggiori portavoce. Erroneamente inoltre, la corrente russa – visto l’inflazionato parallelismo con quella italiana – venne da alcuni collegata alla diffusione di idee fasciste.
Alla luce dei proficui rapporti, in ambito culturale, intessuti agli inizi del XX secolo da Italia e Russia, a partire dalle conferenze di Filippo Tommaso Marinetti, la Regione Autonoma Valle d’Aosta – organizzando la mostra Futurismo Russo – La sfida dell’Avanguardia – ci permette un’ampia analisi di tale movimento e delle sue varie evoluzioni. La vasta retrospettiva, presentandoci più di 200 opere, si rivela la mostra riguardante l’arte russa del primo ‘900 più esaustiva mai realizzata in Italia. Come spesso successe in occasione dei grandi movimenti artistici e di pensiero, i primi bagliori di quella che diventò poi un’audace e variegata corrente si ravvisarono nella letteratura. Il poema “Incantesimo col riso” di Velimir Chlebnikov, scritto tra il 1908 e il 1909, è da molti considerato il primo testo futurista russo: i versi che lo caratterizzano sono composti da parole inventate, generate utilizzando la radice “smech” (riso). La prima pubblicazione futurista, dal titolo “Il vivaio dei giudici” e della cui copertina troviamo in mostra una riproduzione, fu stampata nel 1910 su carta da parati, sfidando le reazioni degli intellettuali e del pubblico tutto. La direzione entusiasmante verso la quale gli uomini d’ingegno si mossero in campo letterario si concretizzò appunto in un’intensa sperimentazione linguistico-poetica, dalla quale ebbe origine il Linguaggio Zaum, presto adottato anche dal teatro, costituito da parole inventate, generate in totale libertà (zaum si traduce letteralmente “al di là della ragione”). Le applicazioni e l’intervento futuristi rivalutarono, inoltre, il potenziale dei dialetti e della terminologia colloquiale, che vennero largamente sfruttati. “Schiaffo al gusto del pubblico”, che rivelò le prime lodevoli ricerche sul linguaggio rivendicando il legittimo diritto degli autori ad arricchire il proprio vocabolario, risale al 1912 e fu il primo manifesto programmatico del movimento. I futuristi, i quali – ancora prima che una vera e propria corrente venisse identificata – solevano autodefinirsi budetljany (gente del futuro, coloro che saranno), tentarono di scuotere l’opinione pubblica e scioccare gli spettatori con gesti propagandistici estremi e fiumi di azioni provocatorie, spesso dando adito ad accese polemiche: si mostrarono per le vie delle città in abbigliamento estroso (note le giacche colorate di Vladimir Majakovskij), utilizzando accessori improbabili o ancora con il volto dipinto. Furono investiti da aspre critiche e attaccati per molto tempo da giornalisti ed esperti; addirittura si dubitò della sanità mentale di alcuni dei maggiori portavoce. Erroneamente inoltre, la corrente russa – visto l’inflazionato parallelismo con quella italiana – venne da alcuni collegata alla diffusione di idee fasciste.
.jpg) Il futurismo russo e le avanguardie, meno noti rispetto ai movimenti europei del medesimo periodo, affondarono le loro impazienti radici nella cultura slava e furono influenzati non soltanto dal futurismo italiano ma anche dall’impressionismo e dalle varie correnti postimpressioniste, grazie alle vaste collezioni di arte contemporanea francese presenti in Russia, al brulicare della cultura importata da riviste e libri e ai viaggi degli artisti in Europa. Numerose sono le caratteristiche salienti dell’approccio espressivo del suddetto filone, spesso ritenuto molto vicino a una sorta di estetica dell’assurdo: frequenti interpretazioni metaforiche ed allegoriche – nonché psicologiche, riavvicinamento al passato, fusione di dinamismo e scomposizione delle forme, una certa coscienza cosmica. Il futurismo non potrà mai essere definito una corrente a sé, ben delineata o addirittura sterile: fu un fiume in piena, un uragano di fervore e di energia rinnovatrice, un’esplosione di nuovi propositi e mirabili idee; fu contaminato e contemporaneamente carburante di cubismo, raggismo, primitivismo e pittura analitica. La mostra ospitata dal Museo Archeologico Nazionale, che da diversi anni presenta al pubblico esposizioni di gran richiamo e rilievo, ci offre alcuni opportuni spunti per elaborare un interessante confronto tra futurismo italiano e futurismo russo, ambedue alimentati in ugual misura dal bisogno di rottura, rivelando sì alcune analogie ma anche numerose differenze sostanziali. Entrambe le correnti focalizzarono la loro attenzione su dinamicità e movimento nonché sulle numerose trasformazioni che stavano avvenendo in ambito economico e sociale, se pur con matrici e ragioni propulsive differenti. Nonostante alcune similitudini formali, in Russia l’integrità stilistica non rappresentò una delle prerogative del movimento: i futuristi russi, ed in questo senso il loro approccio è da considerarsi più genuino – quasi primordiale, volevano piuttosto riappropriarsi delle loro radici, recuperare il loro folclore e le loro tradizioni. Mentre il movimento italiano celebrava il potere della tecnologia e le potenzialità del progresso tecnico e urbanistico, i futuristi russi rimanevano più vicini ai temi umanistici, mostravano grande interesse per i processi naturali, rivalutavano e riscoprivano leggende, miti ed arte popolare. I neoprimitivisti, nelle loro produzioni, fecero spesso uso dei lubok (stampe popolari a soggetto satirico o religioso) mentre il cubofuturismo fu inizialmente ispirato dalle maschere degli Sciti e dalle loro note donne di pietra, così come l’arte africana aveva sedotto ed influenzato il genio di Picasso. Una marcata differenza tra le due realtà si riscontra anche nella concezione della guerra, considerata da un buon numero di italiani un efficace mezzo per ‘rassettare il mondo’ – per liberarsi di tutto ciò che risultava indegno o dannoso, e dai russi quale sinonimo di distruzione della vita, in ogni sua forma. La compagine russa, inoltre, vantava al suo attivo molte donne agguerrite, colte, artiste audaci ed indipendenti, temerarie esploratrici – mentre in Italia il movimento fu pressoché caratterizzato da un radicato maschilismo.
Il futurismo russo e le avanguardie, meno noti rispetto ai movimenti europei del medesimo periodo, affondarono le loro impazienti radici nella cultura slava e furono influenzati non soltanto dal futurismo italiano ma anche dall’impressionismo e dalle varie correnti postimpressioniste, grazie alle vaste collezioni di arte contemporanea francese presenti in Russia, al brulicare della cultura importata da riviste e libri e ai viaggi degli artisti in Europa. Numerose sono le caratteristiche salienti dell’approccio espressivo del suddetto filone, spesso ritenuto molto vicino a una sorta di estetica dell’assurdo: frequenti interpretazioni metaforiche ed allegoriche – nonché psicologiche, riavvicinamento al passato, fusione di dinamismo e scomposizione delle forme, una certa coscienza cosmica. Il futurismo non potrà mai essere definito una corrente a sé, ben delineata o addirittura sterile: fu un fiume in piena, un uragano di fervore e di energia rinnovatrice, un’esplosione di nuovi propositi e mirabili idee; fu contaminato e contemporaneamente carburante di cubismo, raggismo, primitivismo e pittura analitica. La mostra ospitata dal Museo Archeologico Nazionale, che da diversi anni presenta al pubblico esposizioni di gran richiamo e rilievo, ci offre alcuni opportuni spunti per elaborare un interessante confronto tra futurismo italiano e futurismo russo, ambedue alimentati in ugual misura dal bisogno di rottura, rivelando sì alcune analogie ma anche numerose differenze sostanziali. Entrambe le correnti focalizzarono la loro attenzione su dinamicità e movimento nonché sulle numerose trasformazioni che stavano avvenendo in ambito economico e sociale, se pur con matrici e ragioni propulsive differenti. Nonostante alcune similitudini formali, in Russia l’integrità stilistica non rappresentò una delle prerogative del movimento: i futuristi russi, ed in questo senso il loro approccio è da considerarsi più genuino – quasi primordiale, volevano piuttosto riappropriarsi delle loro radici, recuperare il loro folclore e le loro tradizioni. Mentre il movimento italiano celebrava il potere della tecnologia e le potenzialità del progresso tecnico e urbanistico, i futuristi russi rimanevano più vicini ai temi umanistici, mostravano grande interesse per i processi naturali, rivalutavano e riscoprivano leggende, miti ed arte popolare. I neoprimitivisti, nelle loro produzioni, fecero spesso uso dei lubok (stampe popolari a soggetto satirico o religioso) mentre il cubofuturismo fu inizialmente ispirato dalle maschere degli Sciti e dalle loro note donne di pietra, così come l’arte africana aveva sedotto ed influenzato il genio di Picasso. Una marcata differenza tra le due realtà si riscontra anche nella concezione della guerra, considerata da un buon numero di italiani un efficace mezzo per ‘rassettare il mondo’ – per liberarsi di tutto ciò che risultava indegno o dannoso, e dai russi quale sinonimo di distruzione della vita, in ogni sua forma. La compagine russa, inoltre, vantava al suo attivo molte donne agguerrite, colte, artiste audaci ed indipendenti, temerarie esploratrici – mentre in Italia il movimento fu pressoché caratterizzato da un radicato maschilismo.
.jpg) Tra gli innumerevoli capolavori, da ricordare alcune tra le tele più rappresentative: “L’aviatore” e “Ritratto di Ivan Kljun” di Kazimir Malevic, “La fucina” di Ol’ga Rozanova, “Uomo+aria+spazio” e “Ritratto di filosofo” di Ljubov’ Popova e i vari esempi di raffigurazioni raggiste di Mikhail Larionov e della sua compagna Natalija Goncarova. Sempre ad opera della Goncarova è “Natura morta con prosciutto” (1912), dipinto provocatorio ed esempio eccellente di dinamismo guizzante (nonostante si tratti appunto di una natura morta, che di per sé dovrebbe conservare una certa staticità!). Nell’ultima sala della mostra (e quale migliore conclusione?), sono presenti varie ed ampie tele di Pavel Filonov, maestro di pittura analitica per molto tempo considerato insano di mente proprio per via dei suoi dipinti (si osservino “Goletta da pesca”, “Ottobre”, “Vittoria sull’eternità”). Tra le varie opere, tutte di gran rilevanza, prima su tutte emerge oscillante “Degenerazione dell’uomo”, eccezionale dipinto-allegoria che raffigura con inimitabile incisività lo svilimento e l’accasciamento dell’uomo e dunque dell’intelletto. Intorno e dietro al soggetto sconfitto, collocato centralmente, si staglia una cornice di edifici raccolti ed addolorati, anch’essi piegati in avanti, in atteggiamento di sommessa e rassegnata partecipazione. In conclusione, credo sia opportuno ricordare una delle prerogative dello slancio futurista, formulazione oggi più che mai attuale: la più vera modernità, che sia di un popolo o di una concezione, per essere tale, deve nascere dalla riscoperta consapevole delle proprie radici, dall’incontro intenso e festoso con la propria memoria.
Tra gli innumerevoli capolavori, da ricordare alcune tra le tele più rappresentative: “L’aviatore” e “Ritratto di Ivan Kljun” di Kazimir Malevic, “La fucina” di Ol’ga Rozanova, “Uomo+aria+spazio” e “Ritratto di filosofo” di Ljubov’ Popova e i vari esempi di raffigurazioni raggiste di Mikhail Larionov e della sua compagna Natalija Goncarova. Sempre ad opera della Goncarova è “Natura morta con prosciutto” (1912), dipinto provocatorio ed esempio eccellente di dinamismo guizzante (nonostante si tratti appunto di una natura morta, che di per sé dovrebbe conservare una certa staticità!). Nell’ultima sala della mostra (e quale migliore conclusione?), sono presenti varie ed ampie tele di Pavel Filonov, maestro di pittura analitica per molto tempo considerato insano di mente proprio per via dei suoi dipinti (si osservino “Goletta da pesca”, “Ottobre”, “Vittoria sull’eternità”). Tra le varie opere, tutte di gran rilevanza, prima su tutte emerge oscillante “Degenerazione dell’uomo”, eccezionale dipinto-allegoria che raffigura con inimitabile incisività lo svilimento e l’accasciamento dell’uomo e dunque dell’intelletto. Intorno e dietro al soggetto sconfitto, collocato centralmente, si staglia una cornice di edifici raccolti ed addolorati, anch’essi piegati in avanti, in atteggiamento di sommessa e rassegnata partecipazione. In conclusione, credo sia opportuno ricordare una delle prerogative dello slancio futurista, formulazione oggi più che mai attuale: la più vera modernità, che sia di un popolo o di una concezione, per essere tale, deve nascere dalla riscoperta consapevole delle proprie radici, dall’incontro intenso e festoso con la propria memoria.
Futurismo Russo – La sfida dell’Avanguardia
<
BR>Museo Archeologico Regionale di Aosta
Piazza Roncas, 12 Aosta
Fino al 7 aprile 2002
Per informazioni 0165230545
di Sonia Gallesio