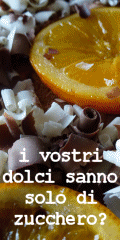Il dibattito in primo piano
Novembre 7, 2004 in Spettacoli da Redazione
.jpg) Fra i quattro festival torinesi di genere, il più vivo, interessante e maturo è sicuramente Cinemambiente. Giunto quest’anno alla settima edizione, l’evento organizzato da Gaetano Capizzi e Stefano Susca ha dimostrato di avere raggiunto la piena maturità trovando la formula giusta con l’eliminazione del concorso lungometraggi che nelle passate stagioni era spesso risultato il tallone d’Achille di una manifestazione che sin dal 1998 ha sempre concentrato le proprie energie sulla dimensione documentaristica. Questa scelta, fatta in tempi non sospetti, risulta premiata da una congiuntura nella quale il documentario si è fatto genere con dignità cinematografica. Cinemambiente è cresciuto per meriti propri, certo, ma ha tratto giovamento da un contesto nel quale molti filmaker hanno scelto di battere le strade del realismo in senso stretto.
Fra i quattro festival torinesi di genere, il più vivo, interessante e maturo è sicuramente Cinemambiente. Giunto quest’anno alla settima edizione, l’evento organizzato da Gaetano Capizzi e Stefano Susca ha dimostrato di avere raggiunto la piena maturità trovando la formula giusta con l’eliminazione del concorso lungometraggi che nelle passate stagioni era spesso risultato il tallone d’Achille di una manifestazione che sin dal 1998 ha sempre concentrato le proprie energie sulla dimensione documentaristica. Questa scelta, fatta in tempi non sospetti, risulta premiata da una congiuntura nella quale il documentario si è fatto genere con dignità cinematografica. Cinemambiente è cresciuto per meriti propri, certo, ma ha tratto giovamento da un contesto nel quale molti filmaker hanno scelto di battere le strade del realismo in senso stretto.
Se gli altri festival minori dell’area torinese – Cinemadonne e il Festival a tematiche omosessuali – hanno (purtroppo) trovato la propria dimensione in uno standard televisivo, privo di contenuti, assolutamente inutile al dibattito, la rassegna a tematiche ambientali ha dimostrato di rimanere aderente ai propri intenti. Nell’anno che ha visto premiare un documentario – Fahrenheit 9/11 di Michael Moore – con la Palma d’Oro al Festival di Cannes, Cinemambiente ha confermato la propria vocazione per un cinema di grande impatto etico in grado di portare a galla vicende ambientali e sociali molto spesso sconosciute o annacquate nel mare magnum dell’informazione globalizzata. Il grande evento della rassegna è stata la prima torinese di The Corporation di Jennifer Abbott e Mark Achbar tratto dall’omonimo bestseller di Joel Balkan. I due filmaker canadesi, supportati dal dream team della cultura “no global” (Naomi Klein, Noam Chomski e Michael Moore), hanno messo a nudo le quotidiane e sistematiche violazioni delle norme etiche da parte della grandi multinazionali.
Anche dal concorso documentari è arrivato un valido contributo al dibattito sulle più scottanti tematiche ambientali. 100% Cotton-Made in India di Inge Altemeier e Reinhard Hornung ha indagato sui metodi di produzione del cotone in India e sulle condizioni di coloro che lo lavorano, Blue Vinyl di Judith Halfand e Daniel B. Gold sui danni provocati dal Pvc, Power Trip di Paul Devlin sui metodi escogitati dai georgiani per non acquistare l’elettricità dalla Aes Corporation, la società che ha sostituito lo stato nell’erogazione dell’energia elettrica. Surplus dell’italo-svedese Erik Gandini partendo da un dato statistico – il 20% del mondo (quello industrializzato) consuma l’80% delle risorse complessive – ha costruito un documentario a sostegno delle idee del guru dell’anti-globalizzazione John Zerzan sui danni della proprietà privata. Con uno stile giovane, un montaggio incalzante e videoclipparo Gandini ha esplorato e definito con grande incisività la natura della cultura del consumo. Sempre dalla Svezia è sbarcato al festival Agent orange di Maj Wechselmann, video-denuncia sui danni causati dall’uranio impoverito sui reduci della guerra del Golfo. I numeri parlano da soli: 203.000 soldati sono malati e 11.000 sono morti. Pretty Dyana di Boris Mitic ha sondato le periferie di Belgrado dove gli zingari si guadagnano da vivere trasformando le loro 2Cv della Citroen in carrette motorizzate destinate a recuperare materiale riciclabile.
In un panorama così eterogeneo si è imposto, a sorpresa, il film meno impegnato: Carpatia di Andrzej Klamt e Ulrich Rydzewsky, un viaggio poetico nei paesaggi rurali di questa regione montuosa che attraversa l’Europa centrale e sud-orientale, un realistico ritratto della gente e dei luoghi dei Carpazi.
Il concorso cortometraggi ha visto imporsi L’evangile du cochon creole di Michelange Quay, mentre nel concorso cinema italiano ha primeggiato Il settimo giorno di Michele D’Onofrio.
Il pubblico torinese ha molto apprezzato la retrospettiva Il cinema corre sul fiume dedicata alle pellicole di ambientazione padano. Sulle rive del fiume Po sono nati alcuni dei più importanti film del neorealismo (Ossessione di Luchino Visconti, Paisà di Roberto Rossellini, La risaia di Raffaele Mattarazzo) e, in tempi più recenti, alcuni autori vi hanno ambientato le loro storie più introspettive (si pensi a La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci o a Notte italiana, opera prima di Carlo Mazzacurati). L’atra retrospettiva ha omaggiato la Panaria film, casa di produzione siciliana fondata dal principe Francesco Alliata che, nell’immediato dopoguerra, cercò di fondare l’industria cinematografica in Sicilia producendo, fra le altre cose, La carrozza d’oro di Jean Renoir e Vulcano di William Mieterle.
Chiudiamo con l’immancabile Late Night Show, creatura di Antonio Copparoni, universalmente riconosciuto come il “maggiore esperto subalpino di fantascienza”. Dopo le esplorazioni nella fantascienza di serie B degli anni Cinquanta, quest’anno il “Coppa” ha omaggiato i cinefili torinesi con una rassegna sulla science-fiction del post-atomico. Da 2019 – Dopo la caduta di New York a …e la terra prese fuoco, da Il giorno dopo la fine del mondo al wendersiano Lo stato delle cose dove lo scenario post-atomico è solo l’incipit.
di Davide Mazzocco