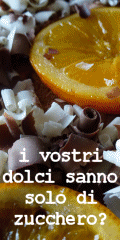Cultura nel cibo
Gennaio 25, 2004 in il Traspiratore da Redazione
Ricordo l’ora di pranzo alle elementari, tanto attesa per immergermi nel caldo tepore della mensa scolastica, enorme e piena di bambini più grandi di me: un momento di condivisione allegra e libera. Forse, la prima condivisione vera e propria che noi facciamo, ancor prima dello scambio di figurine, è proprio lo scambio di cibi. Sì, attraverso il cibo avviene la prima relazione con il mondo, per qualsiasi cucciolo d’ogni specie: il senso di fiducia di base nel mondo esterno si costituisce in primo luogo attraverso il soddisfacimento dei bisogni alimentari. Ma nutrirsi non è solo una questione naturale, di sopravvivenza, è anche e soprattutto uno strumento di comunicazione per esprimere chi siamo, cosa pensiamo, dove viviamo, che relazioni viviamo.
Nella nostra società, “andare a mangiare una pizza”, “prendere qualcosa” sono espressioni che fondamentalmente veicolano il bisogno di stare insieme e conoscersi. Le belle feste di compleanno di quando eravamo bambini ci ricordano panini, patatine, bevande frizzatine, cibi normalmente “proibiti” dalle mamme più salutiste, che creavano tutta quella particolare atmosfera di gioia, di libera e minima trasgressione. L’idea di trasgressione attraverso il cibo ci è ben nota, anche grazie alla televisione: bambini imbrattati di pomodoro o cioccolato con il viso furbescamente soddisfatto, le famose “torte in faccia”, cene d’affari che diventano comiche commedie degli errori… e poi, chissà perché, un vecchio proverbio dice che uno dei tanti modi per conquistare un uomo sia quello di “prenderlo per la gola”!
Il motivo stesso che ci siano tanti divieti, regole, luoghi e momenti per consumare i cibi testimonia lucidamente come nutrirsi sia un fatto culturale. I pasti, ad esempio, segnano le feste: senza spostarci troppo dalle nostre conoscenze, il tacchino del “Giorno del Ringraziamento” americano altro non è che un chiaro simbolo delle tradizioni culturali locali. Spostiamoci in Cina: nei rituali funebri, vengono offerti alimenti semplici o elaborati a seconda della relazione di parentela che lega il donatore al defunto. Trovare collegamenti immediati e numerosi tra elementi culinari e culturali è semplice, soprattutto se muoviamo il nostro punto di vista in qualche altra società, dove il cibo rappresenta ancora un importante rivelatore dello status sociale, in quanto, purtroppo, non tutti hanno accesso agli stessi alimenti.
Il cibo, del resto, è un forte indicatore di alterità culturale: i “cibi tipici”, che si tramandano prevalentemente attraverso le generazioni femminili con gelosia e fierezza, ne sono un valido esempio, così come, d’altro canto, anche le “cene etniche”, che molto spesso seguono i convegni interculturali.
L’argomento dei tabù alimentari è forse il più legato alle credenze, alla filosofia di vita e alle manifestazioni di pensiero delle singole culture. Molto spesso questi tabù sono figli di una particolare religione, come quello della carne di maiale per gli appartenenti alla religione islamica, come altri per chi professa l’Induismo o il Cristianesimo. Tutti conosciamo, ad esempio, la simbologia ebraica dei cibi pasquali: l’agnello, figura di Cristo; i pani azzimi, senza lievito, che indicano le tribolazioni degli Israeliti, ma soprattutto la rottura con i costumi egiziani; le lattughe selvatiche che, con la loro amarezza, simboleggiano il dolore della schiavitù in Egitto.
Lontano dalle concezioni religiose vi sono, invece, i tabù alimentari dei Roma, un gruppo particolare delle popolazioni zingare Rom. Gli zingari generalmente vivono dispersi in mezzo ad un altro popolo a loro ostile, da cui però dipendono per il proprio sostentamento. Ci sono, quindi, continue pressioni per l’assimilazione delle popolazioni zingare da parte della società dominante. Il sistema logico-simbolico che gli zingari hanno messo in atto per continuare ad essere Rom e distinguersi dal Gage (chi non è Rom) è imperniato sul rapporto uomo – animali-di-cui-cibarsi.
Tra i Roma, in particolare, vige il tabù alimentare su qualsiasi animale domestico del proprio campo, perché equiparato affettivamente ai propri parenti. La violazione di questo tabù comporta la morte. C’è di più. I Roma suddividono gli animali in commestibili “puliti” (animali selvaggi, cavalli, pecore), commestibili “sporchi” (polli, maiali, capre) e non commestibili (cani, gatti, lucertole, rane, lumache, animali da campo). I Roma possono cibarsi di animali sporchi perché la sporcizia di questi animali commestibili, che deriva dal loro più stretto contatto con il Gage, è dovuta alla loro dieta e si concentra nell’intestino, che non viene consumato. Il resto della carne rimane puro. E’ invece assolutamente vietato mangiare animali non commestibili, perché essi hanno un rapporto ancora più stretto con il Gage. Questo divieto riporta al limite culturale invalicabile di distinzione Gage/Rom.
Le credenze popolari che attribuiscono significati negativi al gatto sono state arricchite proprio dai Roma; tra di loro, infatti, non vivono gatti. Mangiare cani o gatti, inoltre, è un grave affronto alla società di appartenenza, che comporta l’esclusione dall’identità Rom e la morte. Mangiare quindi è un fatto morale, oltre che sociale, in quanto l’impurità è trasmissibile per contatto da uomo a uomo.
I riti che segnano l’appartenenza ad una certa cultura, alla vita stessa, passano quindi attraverso oggetti materiali, il primo dei quali è il cibo, forse proprio quello che è maggiormente predisposto alla sublimazione…
di C. Inglese