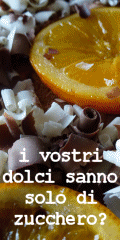Come prima delle madri
Settembre 7, 2003 in Libri da Stefano Mola
Simona Vinci, “Come prima delle madri”, Einaudi, pp. 323, Euro 16,00
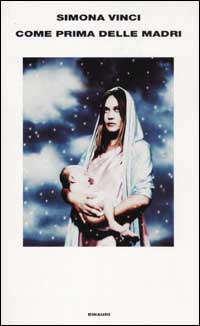
Questa storia è ambientata negli anni 40, attorno al disfacimento del fascismo e all’otto settembre. Pietro, un ragazzino molto attaccato alla madre, viene improvvisamente mandato in collegio senza alcuna spiegazione. Qui, in un incubo di neri e grigi, impossibilitato a comprendere il tradimento della madre, soffrendo anche per la separazione dalla fatata compagna di giochi Irina, si rinchiude in una solitudine quasi autistica, isolato dai compagni. Con la crudeltà tipica del gruppo, viene sottoposto a una dura prova di iniziazione, in cui dovrà esercitare la sua embrionale capacità di scelta.
Il corridoio senza porte del collegio è squarciato dalla guerra: la struttura viene requisita dai tedeschi. Pietro può così tornare a casa. Libero da ogni impegno scolastico, cerca di riappropriarsi dello spazio tra i suoi affetti e le persone che li rappresentano. Ma Irina è nel frattempo morta e la madre sempre più distante. La storia di Pietro si divide quindi tra la scoperta di segreti orribili e angosciosi nel diario di Irina e la selvatica figura di Nina, figlia della servitù di casa e collegata alla nascente resistenza per il forte legame con il fratello.
Ma è bene non andare oltre nella descrizione della trama, per non scalfire troppo la vernice noir di questo romanzo. Pur essendo la dimensione psicologica decisamente prevalente, il colpo di scena che chiude la prima parte e apre alla seconda è fondamentale nell’economia del libro. Cambia il punto di vista (da quello di Pietro a quello della madre) e rompe la sequenzialità temporale della narrazione.
“Come prima delle madri” è un romanzo di formazione. In fondo è la storia di come crescere significhi, tra le altre cose, prendere coscienza che la madre non è soltanto un mantello di affetto protettivo ma una persona con tutti i suoi lati, buchi e relativi spifferi. Questo è chiaramente estremizzato dalle atmosfere particolarmente cupe e dalle vicende a tratti morbose scelte dalla Vinci. Spesso, soprattutto nella prima parte, ambientata nel collegio, la dimensione prevalente è quella dell’incubo. Su tutto toni e colori scuri, nella geometrica claustrofobica degli ambienti. La scrittura della Vinci procede per frasi molto brevi, rare sono le subordinate. È estremamente descrittiva e asettica: anche quando ormai sappiamo che il protagonista si chiama Pietro, ci si riferisce praticamente sempre a lui come “il ragazzo”, utilizzato come soggetto delle frasi. Se vengono citati, oggetti, piante, o animali, sembrano assumere quasi sempre una luce sinistra, o soffocante, quasi simboli inquietanti, di difficile interpretazione.
La seconda parte, in cui il punto di vista è quello della madre Tea, si distende sicuramente meglio. La frattura del colpo di scena centrale (il ritrovamento del diario di Irina) ricarica la vicenda come una molla. Da un lato, permette di giustificare molta della inspiegabile tensione accumulata nella prima parte; dall’altro, riaccende decisamente la curiosità per lo svolgimento successivo della trama, per capire come si saldi la seduzione adolescenziale della madre Tea, alla figura conosciuta all’inizio del libro.
Viene da accostare questa vicenda a quella raccontata da un altro dei libri finalisti, “Cuore di madre” di Roberto Alajmo. Là, il protagonista Cosimo Tumminia crede illusoriamente di essersi emancipato dalla figura della madre, portatrice di un fardello oscuro e quasi tribale di continuità, ma nel momento della scelta non può che fare ricorso a lei, tornando all’interno del suo cerchio oscuro. Qui, Pietro riesce a ripartire “come prima delle madri”, come in una specie di rinascita finale, aperta e non priva di violenza.
Leggete qui un’interessante e approfondita intervista all’autrice
di Stefano Mola