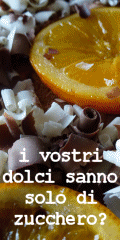Urei, ushabti & C.
Maggio 23, 2003 in Medley da Sonia Gallesio

“Se c’è bisogno di qualcuno per le faccende dell’aldilà, risponderai: eccomi!”. Tratta dal Libro dei Morti (raccolta di formule magico-religiose che permetteva di scongiurare i pericoli della vita ultraterrena), questa espressione veniva incisa sugli ushabti con la precisa funzione di ricordarne il sommo dovere. Il termine ushabti, trascritto anche nella forma uchebti, approssimativamente significa “colui che risponde” (alla chiamata al lavoro, si intende). Anche se alcuni studiosi sostengono che abbia attinenza con la parola shub (avocado) – proprio perché i primi campioni furono realizzati con questo legno – è più probabile che derivi appunto dal verbo usheb (rispondere). Queste statuette funerarie riproducevano l’aspetto del defunto mummificato ed avevano il compito di lavorare nell’aldilà al suo posto. Rappresentavano, insomma, una sorta di manovalanza sostitutiva appannaggio dei giustificati, ovvero di tutti coloro che si erano presentati davanti al tribunale dei morti ed erano stati prosciolti. Deposte nelle tombe, erano realizzate prevalentemente in legno, pietra o terracotta. Avevano le braccia incrociate ed erano equipaggiate di falcetto e cestino, rimandando nello specifico al lavoro nei campi. Gli ushabti vennero impiegati a partire dal Medio Regno e successivamente arrivarono ad essere anche diverse centinaia per ogni defunto. Addirittura, i più facoltosi ne possedettero uno per ogni giorno dell’anno, più una serie di capomastri per dirigerli. Le loro dimensioni variavano da pochi centimetri a qualche decimetro di altezza. Potevano essere deposti direttamente sul suolo, oppure chiusi in piccoli sarcofagi o in cofanetti di legno dipinto. Su di essi erano presenti dei testi in geroglifico – o in alcuni casi in scrittura ieratica – atti all’identificazione del proprietario. Sovente vi era inscritto anche un capitolo del Libro dei Morti, quasi sempre il sesto, nel quale venivano elencati i lavori che la figurina avrebbe dovuto svolgere. Gli ushabti avevano un importante valore simbolico; venivano utilizzati anche da faraoni e personalità di alto rango, difatti, nonostante gli stessi non avessero mai lavorato la terra.
Designante la femmina del cobra, il termine ureo è la versione latinizzata della parola greca ouraios che deriva dall’egiziano iaret. Secondo la mitologia egizia la femmina di questo serpente rappresentava l’occhio di Ra, figlia del dio solare. Il rettile, effigiato nell’atto di ergersi sulla fronte di faraoni e dei, era un’arma al servizio del sovrano, simbolo della forza distruttrice, ma al contempo entità protettrice. L’ureo fu presente sulle fascie-seshed a partire dalla IV dinastia e in particolare dal regno di Snefru, mentre la collocazione definitiva sul nemes avvenne sotto il dominio di Didufri. Nelle altre corone regali venne impiegato successivamente, nel Medio Regno. Nella bella mostra veneziana di Palazzo Grassi è possibile ammirare svariati esemplari di ureo: in un nemes bronzeo, ad esempio, o ancora sulla testa in quarzite di Amenofi III, o sulla parrucca-ibes cinta dal nastro seshed (al fine di rafforzarne il carattere solenne) raffigurata nel modello per scultura in calcare di epoca tolemaica.
 Allo scopo di soddisfare ogni necessità del trapassato, le tombe erano gremite di vasi e contenitori dalle forme e dalle funzioni più disparate. Recipienti colmi di olio, vino, miele, cereali. Oppure unguenti, grasso, cosmetici. E poi c’erano i vasi canopi, per la conservazione delle viscere del defunto. Alla fine della III dinastia (2700-2620 a.C.), infatti, entrò in uso l’eviscerazione addominale e di qui la necessità di raccoglierle e conservarle. La funzione dei canopi è stata scoperta da Jean-François Champollion tramite l’osservazione del loro contenuto. Sono suoi questi frementi appunti: “Tessuto fibroso […]/Odore animale/Trovato in fondo al vaso/L’oggetto impregnato e ricoperto di uno spesso strato di balsamo/Avvolto in semplice stoffa […]/Si tratta di fegato, di cervello o di cervelletto”. Al tempo, gli imbalsamatori ricevevano il corpo due o tre giorni dopo il decesso e per prima cosa procedevano ad estrarre le viscere attraverso un’incisione addominale praticata sul fianco sinistro. Prelevavano il fegato, lo stomaco, gli intestini ed infine i polmoni. Di solito il cuore veniva lasciato al suo posto: dimora e scrigno dei sentimenti e della vita stessa, si credeva fosse importante non separarlo dal resto del corpo. L’ablazione del cervello, invece, fu praticata soltanto a partire dal Nuovo Regno. Con l’ausilio di un lungo uncino di bronzo introdotto nella narice sinistra, veniva sfondata la lamina cribrosa dell’etmoide (osso che separa le fosse nasali dalla parte anteriore del cranio) in modo da poter procedere all’asportazione dell’intera massa cerebrale. La cavità cranica veniva poi riempita da resina liquefatta.
Allo scopo di soddisfare ogni necessità del trapassato, le tombe erano gremite di vasi e contenitori dalle forme e dalle funzioni più disparate. Recipienti colmi di olio, vino, miele, cereali. Oppure unguenti, grasso, cosmetici. E poi c’erano i vasi canopi, per la conservazione delle viscere del defunto. Alla fine della III dinastia (2700-2620 a.C.), infatti, entrò in uso l’eviscerazione addominale e di qui la necessità di raccoglierle e conservarle. La funzione dei canopi è stata scoperta da Jean-François Champollion tramite l’osservazione del loro contenuto. Sono suoi questi frementi appunti: “Tessuto fibroso […]/Odore animale/Trovato in fondo al vaso/L’oggetto impregnato e ricoperto di uno spesso strato di balsamo/Avvolto in semplice stoffa […]/Si tratta di fegato, di cervello o di cervelletto”. Al tempo, gli imbalsamatori ricevevano il corpo due o tre giorni dopo il decesso e per prima cosa procedevano ad estrarre le viscere attraverso un’incisione addominale praticata sul fianco sinistro. Prelevavano il fegato, lo stomaco, gli intestini ed infine i polmoni. Di solito il cuore veniva lasciato al suo posto: dimora e scrigno dei sentimenti e della vita stessa, si credeva fosse importante non separarlo dal resto del corpo. L’ablazione del cervello, invece, fu praticata soltanto a partire dal Nuovo Regno. Con l’ausilio di un lungo uncino di bronzo introdotto nella narice sinistra, veniva sfondata la lamina cribrosa dell’etmoide (osso che separa le fosse nasali dalla parte anteriore del cranio) in modo da poter procedere all’asportazione dell’intera massa cerebrale. La cavità cranica veniva poi riempita da resina liquefatta.
I Faraoni a Venezia
Gli Artisti del Faraone
Museo Egizio
Ostraca, fogli di pietra
di Sonia Gallesio