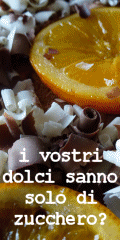TraspiGrinzane
Maggio 11, 2003 in Libri da Stefano Mola
Boris Biancheri, “Il ritorno a Stomersee”, Feltrinelli, pp.165, Euro 13,00
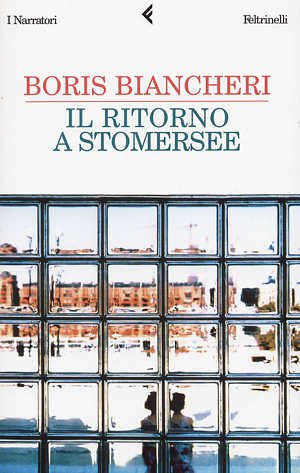 “Il ritorno a Stomersee” è un libro di tre racconti. Nel primo, che dà il titolo alla raccolta, una anziana signora ritorna nella Lituania della sua giovinezza. La sua lucidità è ormai molto ridotta, è avvolta in stanchezza e confusione, fatti e oggetti del presente perdono di definizione, sfumano verso il passato. Nel viaggio verso la dimora di Stomersee, ricompaiono le scene dell’amore che ha vissuto, e quasi imposto, per un giovane coetaneo reso infermo dalla guerra. Nel secondo, “Un banale errore”, un professore italiano che si trova in Giappone per un convegno sbaglia treno, scende e alla stazione si infortuna alla schiena. Viene raccolto dalla giovane ed enigmatica giapponese Reiko, che si prende cura, anche eroticamente, di lui. Il professore si abbandona in quell’ansa casuale del tempo, lasciandosi scomparire dal mondo, e non rispondendo alle ricerche dei parenti. Nel terzo, “Le pietre di Panayotis”, il giovane console italiano Fabrizio rimane con la sua barca in panne vicino a un’isola pietrosa dell’Egeo, i cui soli abitanti sono una famiglia di quattro persone e un prete, divisi da un odio profondissimo. Il console non potrà far altro che assistere al consumarsi di una tragedia.
“Il ritorno a Stomersee” è un libro di tre racconti. Nel primo, che dà il titolo alla raccolta, una anziana signora ritorna nella Lituania della sua giovinezza. La sua lucidità è ormai molto ridotta, è avvolta in stanchezza e confusione, fatti e oggetti del presente perdono di definizione, sfumano verso il passato. Nel viaggio verso la dimora di Stomersee, ricompaiono le scene dell’amore che ha vissuto, e quasi imposto, per un giovane coetaneo reso infermo dalla guerra. Nel secondo, “Un banale errore”, un professore italiano che si trova in Giappone per un convegno sbaglia treno, scende e alla stazione si infortuna alla schiena. Viene raccolto dalla giovane ed enigmatica giapponese Reiko, che si prende cura, anche eroticamente, di lui. Il professore si abbandona in quell’ansa casuale del tempo, lasciandosi scomparire dal mondo, e non rispondendo alle ricerche dei parenti. Nel terzo, “Le pietre di Panayotis”, il giovane console italiano Fabrizio rimane con la sua barca in panne vicino a un’isola pietrosa dell’Egeo, i cui soli abitanti sono una famiglia di quattro persone e un prete, divisi da un odio profondissimo. Il console non potrà far altro che assistere al consumarsi di una tragedia.
Scrivere un libro di racconti riuscendo a farne un’opera unitaria non è cosa facile. Si possono scrivere storie brevi, metterle insieme, e basta. Se il paragone non sembra irrispettoso, pensiamo alla differenza che c’è tra Sgt Pepper’s e il Double White. Entrambi sono dischi dei Beatles. Entrambi sono ricchi di canzoni importanti e molto belle. Ma il primo, ha una marcia in più. È come uno spettacolo teatrale ripieno di storie. C’è un disegno unitario, ma i singoli pezzi non sono affatto uguali. Il volume di Biancheri è della razza di Sgt. Pepper’s. C’è un disegno unitario, e per darne un’idea ricorrerei ancora alla musica. L’immagine che mi viene in mente è quella della variazione. Una cosa come le variazioni Goldberg di Bach. Anche lì c’è un fortissimo disegno unitario a partire da un tema, ma ogni variazione ha dignità assoluta.
Provo a dare un’idea della rete sottile di echi e rimandi che sta alla base di questi tre racconti. Per prima cosa, in tutti e tre i racconti, compaiono dei consoli. Nei primi due svolgono un puro ruolo di testimonianza, sfiorando soltanto la vicenda. Non riescono, per rifiuto, per impossibilità o per incompleta comprensione, a lasciare una traccia nelle vicende in cui il caso li coinvolge. Nell’ultimo, il ruolo di testimone si colora di una sfumatura particolarmente drammatica. Per la sua giovane età, per la fiducia in se stesso, perché fino a quel momento non è stato ancora toccato dal male del mondo, per il ruolo che immagina di assumere, il giovane Fabrizio si illude che la parola possa incidere. Non potrà invece far altro che osservare il compimento della violenza e restarne segnato per sempre. In questo caso, la variazione è la prospettiva: vediamo le cose dal punto di vista del testimone, nei primi due racconti i testimoni scivolavano accanto al nucleo delle storie senza coglierlo. Inoltre, il testimone si trova ad essere direttamente coinvolto e inciso dalle vicende narrate. Anche perché si viene trascinato in prima persona nell’ansa del tempo.
Ecco un secondo filo: in tutti e tre i racconti c’è un luogo recluso, una bolla di sospensione nel tempo, qualcosa di “staccato” dallo scorrere “lineare”, o da quello che si immagina tale. Il castello di Stomersee isolato durante la seconda guerra mondiale nel primo. La casa di Reiko nel remoto villaggio giapponese da cui il professor Bloff non si vuole allontanare nel secondo. La misera e arida isola greca nel terzo.
L’isolamento nello spazio provoca un’immobilità nel tempo, o anche l’illusione di una sospensione dal tempo. Che trova una dualità sul piano dei sentimenti dei personaggi. I luoghi diventano probabilmente solo un pretesto, una porta laterale che permette una scappatoia, solo apparente. Una vera fuga presupporrebbe una volontà forte. Nei personaggi di Biancheri c’è piuttosto un abbandono alla situazione, uno sfuggire alla compiutezza psicologica, soprattutto nei rapporti amorosi. La signora Sartorius a un certo punto decide di innamorarsi del povero infermo Charlie, e non si capisce mai veramente se quest’ultimo la ami veramente o piuttosto si rassegni per mancanza di volontà alla determinazione di lei. Allo stesso modo, il professor Bloff, che si trova anch’esso in una situazione di infermità, seppur momentanea, viene scelto da Reiko. Ma il loro rapporto non verrà mai formalizzato a parole, resterà sempre avvolto in un’aura di ambiguità. Così come affettivamente incompiuto è il prete dell’isola, che non riesce ad abbandonare il desiderio carnale terreno. Quindi, un altro filo ancora: una situazione di infermità fisica, come nelle prime due storie, che si fa incertezza, debolezza, rifiuto o pretesto per irresponsabilità emotiva. Anche nel terzo c’è comunque qualcosa che si inceppa e che immette nella bolla spazio-temporale: l’avaria alla barca.
Boris Biancheri ha narrativamente la forza di scegliere situazioni originali senza che siano forzatamente eccentriche, e di portarle avanti fino al compimento. Fa questo con una scrittura piana e precisa, prendendo una giusta distanza dai personaggi, che lascia il giusto spazio all’ambiguità. Esemplare da questo punto di vista è “Un banale errore”, dei tre secondo me il più riuscito. Biancheri racconta senza imporre interpretazioni, anche se “Le pietre di Panayotis” grazie alla sua concretezza pietrosa, riesce ad avere la forza di una parabola.
Nel sito della casa editrice Feltrinelli, potete ascoltare una intervista all’autore
di Stefano Mola