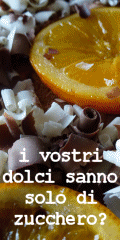Traspi.net per il Grinzane
Aprile 15, 2002 in Libri da Stefano Mola
Romana Petri, “La donna delle Azzorre”, Piemme, pag. 155, Euro 12,91
.jpg) Una donna italiana passa da sola l’estate a ( Pico (isola delle Azzorre). È un’insegnante di francese, cerca forse la pace di un tempo sospeso, si è portata dietro molti libri da leggere. Pico è un’isola di origine vulcanica, spazzata dai venti e frustata dall’oceano, una terra che alterna coltivazioni rigogliose a colate laviche ricoperte di sterpaglie (i misterios). Una terra povera, popolata di gente semplice, spesso costretta nel passato ad emigrare per vivere.
Una donna italiana passa da sola l’estate a ( Pico (isola delle Azzorre). È un’insegnante di francese, cerca forse la pace di un tempo sospeso, si è portata dietro molti libri da leggere. Pico è un’isola di origine vulcanica, spazzata dai venti e frustata dall’oceano, una terra che alterna coltivazioni rigogliose a colate laviche ricoperte di sterpaglie (i misterios). Una terra povera, popolata di gente semplice, spesso costretta nel passato ad emigrare per vivere.
Sarà la suggestione geologica delle colate laviche, ma i libri più belli sono quelli che si possono leggere a strati. Il primo strato di questo libro è fatto dalle storie della gente di Pico. Tranne il capitolo iniziale e i due capitoli finali, tutti gli altri prendono il nome dalle persone che la donna via via incontra. Sono tutte storie di emigrazione, quindi di precarietà, di incerto e forse impossibile equilibrio tra l’identità originaria e quella del paese ospitante. Ma sono sempre storie d’amore: se coniugale è al tempo stesso intenso e semplice, necessità primaria come gli elementi naturali senza i quali la vita non è possibile, pelle. Se l’amore non è consumato diventa rimpianto che scorre sordo sotto tutta la vita.
Tutte le storie sono viste dalla prospettiva conclusa e lontana della vecchiaia. Spesso quindi la morte è presente, ma in questa terra sospesa (tra il vento e il mare, terra precaria proprio perché vulcanica) si confonde alla vita: “la morte si è fatta lunatica e pellegrina, qualche volta se ne va a prendere il posto della vita” [pag. 146]. Si confonde così tanto che frequenti sono le apparizioni, non diciamo fantasmi o visioni, come se la condizione di precarietà, di distacco, l’intensità dell’amore al di là della morte, la forza del rimpianto per quello che non è stato fossero in grado di dare materia a chi materia non è più. E la forza di tutto questo è tale che spesso la donna vive le apparizioni in prima persona. Dicendo questo non vorrei dare l’impressione che questo libro sia fatto di storie di fantasmi. Le apparizioni completano e prolungano gli accadimenti reali, i pensieri e le emozioni dei personaggi. Del resto, lo sguardo che noi appoggiamo sulle le cose coincide forse con le cose stesse? La prima apparizione è quindi l’illusione che costruiamo per noi stessi. Come dice uno dei personaggi, Isabel Lima, “Non si è mai realisti per davvero, ce lo insegna l’arte che è sempre irreale per troppo ingombro della vita” [pag. 102]. O anche, verso la fine del libro, Maria Moniz dice alla donna “Non si spaventi […] esiste solo quello che si vede, ci siamo e non ci siamo, mica conta molto” [pag. 133].
Del resto, l’emigrazione è prolungamento, sospensione della coscienza tra due luoghi (così come la terra vulcanica è precariamente sospesa tra vitalità e distruzione): questo si rispecchia nella incerta collocazione di chi non c’è più, come se chi si è trovato da vivo tra due luoghi o non è riuscito a vivere il suo amore faticasse a trovare un posto anche da morto. Un altro personaggio, Malvina Sebastiao, tra i più belli del libro, dice “a lungo andare il male arriva fino in fondo, dentro l’anima, la nutre, la fa pesante, e l’anima, al momento suo di andarsene, resta spaesata, non sa prendere la strada leggera dell’altitudine che le spetta, e resta qui, sulla terra, ci resta pure se sa che non è più il suo posto” [pag. 77].
La donna è sempre più coinvolta da queste storie e da questa gente, sospesa tra l’attrazione per una semplicità probabilmente perduta (“Però mi fa una gran malinconia […] e me l’immagino questa gente che se va con il cuore tanto pieno di speranza che già nel viaggio si vuota del passato” [pag. 147]) e la realtà irrimediabile del presente, fatta di persone che sono diventate qualcos’altro, di figli di immigrati che hanno perso del tutto l’impronta di Pico, vestono a braghe larghe come i pari età americani.
Ecco quindi come il resoconto di una vacanza si allarga a ventaglio, diventa anch’esso qualcos’altro, una riflessione sull’identità, sulla precarietà dell’esistenza, sulla persistenza delle passioni, sull’illusione, sulla felicità. Lo sguardo della donna si rispecchia e si riflette nel paesaggio e nei personaggi: tutto è vissuto con intensità, tra attese deluse e scoperte. Sono molte le frasi che verrebbe voglia di trascrivere, annidate tra una descrizione di un personaggio e quella di un paesaggio. Riflessioni tracciate in una lingua asciutta, scarna ma assolutamente incisiva, precisissima, capace in pochi tratti di definire una sensazione, uno stato d’animo o dell’anima, e allo stesso tempo di restituirci un paesaggio, un’isola.
di Stefano Mola